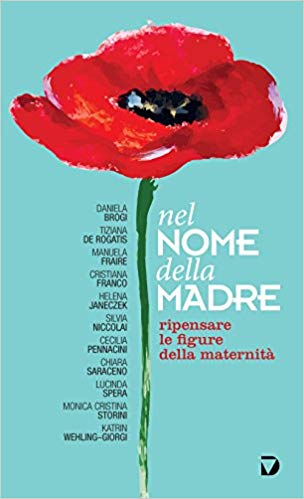Mi decido a recensire un volume apparso qualche tempo su tema, quello della maternità, che tiene conto del desiderio delle autrici di confrontarsi in maniera aperta, provando a sperimentare – nel convegno di cui il testo riporta i materiali – uno sguardo “che trasformasse il mondo della madre in un’avventura, in qualcosa che non è soltanto, ma che esiste nel tempo”. La nostra cultura, in maniere diverse, tende a fissare “la madre” in una figura senza tempo, da celebrare o da rimuovere, a seconda dei contesti e delle epoche, ma bloccata in un movimento senza divenire. Parlare (anche) nel nome della madre significa invece organizzare nuove forme di percezione, scendere nel campo dell’esperienza, delle costruzioni sociali, dei discorsi e delle narrazioni che hanno un inizio e una fine, ma soprattutto dei regimi discorsivi riconoscibili: il mito, la letteratura, l’antropologia, la sociologia, il diritto e la psicanalisi. Proprio il taglio interdisciplinare serve come da guida al tema e mostra tutti i movimenti compiuti intorno a una figura che è tutt’altro che immobile.
Il saggio di Chiara Saraceno mostra l’incessante lavoro di costruzione sociale intorno alla maternità e mette in chiaro, ancora una volta, che anche intesa solo come funzione la maternità non ha niente di “naturale”: la maternità affettiva e accudente che pensiamo discendere da una mentalità tradizionale è in realtà il prodotto di un lungo processo di acculturazione e costruzione che ha impegnato tutta l’età moderna e contemporanea. “Paradossalmente – scrive Saraceno – potremmo dire che proprio il processo intenzionale di modernizzazione (che ha messo al centro la relazione madre-figlio), ha avuto come esito una nuova naturalizzazione delle donne-madri” con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di ricerca di una “misura adeguata” di affettività. “Madri coccodrillo, madri elicotteri, madri tigri” la letteratura colta e quella manualistica si sono attribuiti il compito di suggerire e sanzionare “il troppo poco e il troppo di affetto, cure, attenzione, investimento e dedizione” delle donne in carne e ossa che negli ultimi cento anni si sono trovate a modulare la propria identità materna con i modelli e le aspettative di una società, non solo quella occidentale, in preda alla velocità e ai cambiamenti radicali di direzione dovuti anche allo sviluppo tecnologico.
Manuela Fraire, da psicanalista, si confronta con uno degli esiti di questa velocità, e mostra come la semplice possibilità di fare ricorso alle tecnologie riproduttive, cambia l’idea di procreazione e rivoluziona profondamente quella di maternità. Quello che è interessante per lei è analizzare lo scarto che si crea fra la decisione di avere figli e la difficoltà, per molte, di rimanere incinta, una sorta di “sciopero del corpo” che misura lo scarto fra desiderio e concepimento, il residuo e la traccia di un materiale inconscio sottovalutato e rimosso. Si ripropone, in una cultura come la nostra, in cui gli spazi di intimità vengono continuamente violati, telematicamente e medicalmente, il diritto al segreto, a uno spazio immaginario in cui la nascita abbia un’origine profonda, in cui l’incontro fra corpi e desideri non sia scalzato del tutto dal possibile contributo delle biotecnologie. Tutelare questo spazio indicibile può essere una strategia per tutelare una grande libertà femminile, conquistata dai movimenti femministi nella seconda metà del secolo scorso e oggetto privilegiato degli attacchi neo-patriarcali, quello della maternità indipendente, la “madre sola” che fa i figli fuori dal matrimonio e che può scegliere il partner o “la” partner della sua impresa. Un’impresa da vivere senza lasciarsi catturare dal discorso neutro sulla genitorialità.
Silvia Niccolai entra con forza in uno dei temi che negli ultimi anni stanno facendo discutere. Il suo saggio “Liberare la maternità lesbica dal discorso neutro sull’omogenitorialità: interesse di tutte (e di tutte)” si chiede come non dare campo a un discorso che, fondendo le figure di padre e madre, in un ideale di cura che si risolve nel “fare i genitori”, rischia di promuovere indirettamente e “corposamente”, dice lei, un’aspirazione di tipo patriarcale: “cancellare proprio il senso indipendente della maternità, ovvero la capacità femminile di creare esistenza sociale senza autorizzazione dall’esterno”. Come si può difendere questa libertà senza affidarsi al discorso neutro di un diritto che ragiona sottraendo e tacitando le differenze? Come si può articolare un discorso sulla maternità lesbica senza che ne vengano oscurate le specificità rispetto alla genitorialità omosessuale? Questa domanda, ovviamente, introduce il capitolo più complicato quello della “maternità surrogata”, o della “gestazione per altri”, un tema che ancora più profondamente, se non adeguatamente pensato e formulato (una proposta è già nel rinominarla come “maternità solidale”), rischia di cancellare definitivamente “l’eccedenza” del materno e di portarlo alla sua soglia minima, quella biologica.
Che non sia una strada unica quella su cui si può pensare e vivere la maternità lo mostra bene il saggio di Cecilia Pennacini (Altre madri. Culture della maternità nell’Africa subsahariana). Il punto di vista di un’antropologa mostra come il discorso coloniale abbia organizzato le società che ruotavano intorno alla famiglia poliginica, riducendo di fatto il potere delle donne che, oltre a sentire (e subire) il peso della riproduzione affidata loro, avevano in molti casi elaborato strategie, modelli e figure in grado di fare da contrappeso, giocando ad esempio sull’identità di genere, sul peso simbolico di alcune figure sacerdotali e altre forme di potere femminile.
Alcuni saggi del libro sono dedicati alla letteratura, a scrittrici riprese dal dibattito femminista e sottratte all’abitudine di scrivere manuali di storia della letteratura che non le prevedeva: Alba de Cespedes, nel saggio di Lucinda Spera (“L’anima mia è con te”: figure della maternità nell’archivio personale e nella produzione narrativa di Alba Céspedes) , Goliarda Sapienza nel saggio di Katrin Wehiling-Giorgi (“Dislocazioni materne: memoria, linguaggio e identità femminile nell’opera di Goliarda Sapienza”).
Chiude il volume un contributo di Helena Janeczek, bellissimo. “Mia madre è stata ad Auschwitz ed io sono figlia di mia madre”. Per capire la sua storia di figlia e rendere conto del vissuto di sua madre, la scrittrice si spinge in un campo minato dal trauma della persecuzione, chiedendosi coraggiosamente, come sia passato da una generazione all’altra. Come si sono depositate le ossessioni misogine dell’immaginario nazista nei corpi e nelle menti delle donne che sono sopravvissute ai campi? E’ questo desiderio di “prosciugare il grembo materno”, obiettivo finale dell’eugenetica di Hitler il motivo che ha portato tante donne, compresa la madre di Janeczek, a dover passare da tanti tentativi non andati a buon fine per arrivare a una gravidanza? Di che natura è o può essere un desiderio di maternità così intrecciato a un passato di morte? E come può una donna, una madre, non trasmettere, suo malgrado, la violenza subita, l’autoritarismo arbitrario, la paura e anche quel senso di colpa di cui molti dopo i lager hanno parlato, per il semplice fatto di essere rimasti viva?
Chiudere il saggio con queste pagine, far passare il tema e l’esperienza della maternità da strade tanto dolorose, senza infingimenti o tentativi edificanti, è la prova più chiara dell’ atteggiamento non ideologico con cui le autrici hanno provato a parlare nel nome della madre.
Sandra Burchi in DWF (120), In movimento. Conversazioni politiche, 2018, 4